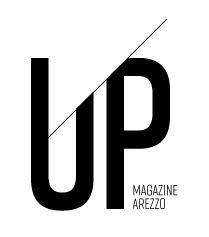Un possente edificio lungo via Romana che nella seconda metà del Duecento era la struttura meglio attrezzata per accogliere i malati del territorio. Nel corso del tempo fu trasformato in centro per la lavorazione e il commercio di cereali, attività portata avanti per più generazioni dalla famiglia Gudini fino a pochi decenni fa
Ci sono luoghi davanti ai quali passiamo in continuazione, ma presi dal trantran quotidiano non cogliamo la storia che ancora trasuda dalle loro pietre. Eppure le tracce del passato sono lì, ben visibili e desiderose solo di essere osservate e riscoperte.
È questo il caso dell’antico lebbrosario di Arezzo, il possente edificio che si incontra lungo via Romana, nella zona che prende il nome di San Lazzaro proprio dall’ex ospedale di origine medievale. La costruzione è già documentata nella seconda metà del Duecento, il secolo in cui ci fu la maggi ore diffusione della lebbra in Occidente. Si calcola infatti che in quel periodo funzionavano in Europa circa 19.000 lazzaretti, che ospitavano le persone colpite dalla terribile malattia infettiva.
Fondato dalla Comunità di Arezzo, il San Lazzaro era la struttura meglio attrezzata per accogliere i malati del territorio. Se la famiglia del paziente non poteva pagare la degenza, il Comune concedeva il ricovero gratuito.
L’entrata nel lebbrosario segnava purtroppo un punto di non ritorno per il malcapitato e l’internamento aveva un carattere di cerimonia funebre, perché per la collettività il lebbroso era un morto vivente.
A partire dagli anni Trenta del Quattrocento l’ospedale aretino fu interessato da un generale rifacimento. A quel secolo apparteneva anche il loggiato, di cui affiorano oggi molti elementi nella facciata, come le sei arcate tamponate, parti di colonne e resti di capitelli in stile ionico. All’interno del complesso uomini e donne vivevano in settori separati, c’erano inoltre la casa dello “spedaliere” e un oratorio per le funzioni religiose.
Dal XVI secolo l’ospedale di Santa Maria del Ponte (o Sopra i Ponti), il più importante della città, visse una grave crisi finanziaria. Per incrementarne le entrate Comune e Fraternita dei Laici tentarono più volte invano di chiudere il lazzaretto, con l’obiettivo di devolvere le sue rendite al nosocomio principale.
Lo stato di disagio si acuì nei primi decenni del XVII secolo. Il 3 dicembre 1623 l’accorpamento delle due strutture ospedaliere andò finalmente in porto e il San Lazzaro, ormai privo di lebbrosi, si trasformò in convalescenziario.
Il 29 ottobre 1784 l’ex lazzaretto e il suo oratorio, considerati da tempo “inutili e di niuno uso”, furono acquistati dai Dini per 530 scudi. Il loro grande stemma familiare è visibile sulla facciata. Nel 1819 il sacerdote Antonio Dini, come recita un’iscrizione parzialmente perduta, fece realizzare una nuova chiesetta.
Dalla metà dell’Ottocento l’intero complesso passò alla famiglia Gudini, i cui discendenti sono tuttora i proprietari dell’immobile. Il San Lazzaro venne trasformato in centro per la lavorazione e il commercio di cereali, attività portata avanti per più generazioni fino a pochi decenni fa.
Nella sua storia plurisecolare il lebbrosario di Arezzo è stato luogo di grande dolore, ma anche lodevole esempio di sanità pubblica medievale. Non sono mancati nemmeno gli episodi curiosi, come la scaramuccia tra sessi opposti del 1603. Nel rapporto dettagliato, custodito oggi nell’Archivio di Stato di Arezzo, si scaricarono tutte le responsabilità sulle donne e sulla loro – testuali parole – “lingua pestifera”.
“Errare è umano; dare la colpa a un altro lo è ancora di più” scrive Max Jacob. I maschi lo sapevano bene anche allora.