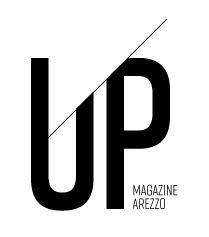Arte, storia e amori per le vie di uno dei borghi più belli d’Italia
Geolocalizzazione
Straordinario esempio di urbanistica medievale, Lucignano si erge sulla sommità di un colle al confine tra il territorio aretino e quello senese, al centro di importanti percorsi viari che fin dall’antichità permettevano i collegamenti tra il mar Tirreno e
gli Appennini attraverso la Val di Chiana. Il suo tipico impianto ellittico a tre anelli concentrici, il centro storico fatto di angoli poetici che seducono i visitatori di tutto
il mondo, il patrimonio artistico plurisecolare custodito e la bucolica campagna circostante, permettono a Lucignano di far parte a pieno titolo del “Club dei borghi più belli d’Italia” e di essere una delle mete preferite dai turisti che vanno alla scoperta della terra d’Arezzo.
Un luogo antico e strategico, da sempre conteso
La presenza umana nel territorio di Lucignano è documentata dalle tracce lasciate già nel Paleolitico e nel Neolitico. I reperti provenienti dalle ricche necropoli di Casalta e Moscino, come i tre splendidi vasi a figure rosse del V secolo a.C. custoditi nel Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” di Arezzo, dimostrano che in epoca etrusca viveva nella zona una ricca aristocrazia agraria. Il toponimo potrebbe essere un prediale che fa riferimento alla gens Licinia, che nella zona doveva avere possedimenti. Secondo la tradizione, invece, Lucignano fu fondata nel I secolo a.C. quando i romani realizzarono un castrum chiamato Lucinianum in onore del console Lucio Licinio Lucullo, generale e
politico al servizio di Silla. Per la sua collocazione strategica, il libero comune nel medioevo fu conteso ripetutamente tra Arezzo, Perugia, Firenze e Siena. Nei primi anni Settanta del XIV secolo, in piena dominazione di quest’ultima, il borgo vide il completamento del circuito murario più esterno. Nel 1552 Lucignano venne conquistata dai fiorentini, quindi fu ripresa dalla Repubblica di Siena per un breve periodo e definitivamente sottomessa ai Medici nel 1554. Da allora perse il suo ruolo strategico di fortilizio di confine e seguì le sorti della nuova dominante, entrando a far parte del Ducato di Firenze, dal 1569 Granducato di Toscana, fino all’annessione al Regno d’Italia con il plebiscito del 1860.

A spasso tra vicoli pittoreschi, architetture militari e prestigiosi palazzi
Le due entrate principali al centro storico sono Porta San Giusto a sud ovest, connotata dallo stemma mediceo, e Porta San Giovanni a nord est, in passato sovrastata da una torre. A queste si aggiungono due ingressi cittadini minori: Porta Murata, chiusa nel Cinquecento, e Porta Sant’Angelo, chiusa alla fine del Settecento, entrambe riaperte nel secolo scorso. La Rocca, costruita dai senesi tra il 1390 e il 1392, è uno degli elementi architettonici distintivi del borgo. Persa la sua funzione militare già dalla seconda metà del Cinquecento, fu adibita a deposito del grano e trasformata nel 1829 in ambiente teatrale. Ancora oggi il Teatro Rosini di Lucignano è uno dei più vivaci della provincia di Arezzo.
Nell’omonima piazza si trovano le cinquecentesche Logge volute dai fiorentini, con cinque arcate a tutto sesto sormontate da una terrazza panoramica. Lungo via Matteotti, l’antico “borgo ricco”, si trovano invece edifici privati di varie epoche appartenuti a famiglie facoltose, come Palazzo Arrighi Griffoli, Palazzo Arnaldi Capei e Palazzo Battelli Renzuoli. Sempre sulla via principale del centro storico lucignanese è ubicato l’ex Ospedale di Sant’Anna con il suo oratorio, fondato nel 1397 per accogliere malati, pellegrini e poveri.
Lucignano è splendidamente turrita. Oltre a quelle delle Rocca, come non citare la caratteristica Torre delle Monache dell’XI/XII secolo nel piazzale dietro la chiesa di San Francesco, oppure i resti della Torre Picconi del XV secolo, visibile lungo le mura nei pressi di Porta San Giovanni, dalla tipica forma circolare.
Vicoli indimenticabili, nella bella stagione ornati di fioriere, salgono dalla parte bassa della cittadina verso la piazza del Tribunale, che accoglie il Crocione ligneo su basamento di pietra e alcuni degli edifici pubblici più importanti.
Il Palazzo Comunale, già Palazzo Pretorio, fu costruito nel corso del XIV secolo. La sua Sala del Consiglio venne affrescata da Luigi Ademollo nel 1812. Il piano terra dell’edificio, in origine sede del Tribunale e delle Prigioni, ospita il Museo Civico con opere di grande valore, che vanno dal Duecento al Settecento. Il cuore magico della pinacoteca è la Sala della Cancelleria o delle Udienze, affrescata nel Quattrocento con volte e lunette che raffigurano uomini e donne virtuosi tratti dalla storia greca, romana e cristiana, che con i loro comportamenti dovevano essere di esempio ai funzionari che amministravano la giustizia. Al centro della sala, in una grande teca di cristallo, si ammira il magnifico “Albero d’oro”, capolavoro dell’arte orafa del Trecento.
L’Albero d’oro di Lucignano, meraviglia dell’oreficeria e simbolo di amore e fedeltà
Meta prediletta di coppie da tutto il mondo, che rinnovano la loro promessa d’amore di fronte all’opera, il celebre “Albero d’oro” è un reliquiario alto oltre due metri e mezzo, realizzato per la Chiesa di San Francesco in due periodi distinti. La parte che ha l’aspetto di una pianta riprende un’immagine francescana ispirata all’opuscolo di meditazioni “Lignum Vitae” di Bonaventura da Bagnoregio scritto intorno al 1260, nel quale il tema dell’albero della vita che Dio pose nel giardino dell’Eden si lega alla storia della croce su cui fu immolato Gesù.
In passato la sua parte più datata, quella di metà XIV secolo, era stata attribuita a Ugolino da Vieri, il più importante orafo di Siena del Trecento, ma oggi è assegnata a una bottega aretina influenzata dalla scuola senese, a quei tempi ai vertici dell’oreficeria europea. L’opera rimase incompiuta per circa 120 anni, finché il lascito della pia Madonna Giacoma garantì le risorse per il completamento, portato a termine dal senese Gabriello d’Antonio negli anni Settanta del Quattrocento.

L’albero di Lucignano è in rame dorato e argento. Il piede e una base più piccola sorreggono una teca reliquiaria a forma di tempietto gotico, con tre ordini sovrapposti di bifore, sulla quale si inserisce il fusto da cui si spiegano dodici rami arricchiti con foglie di vite e piccole teche trilobate, che servivano a conservare reliquie francescane e schegge della Santa Croce. Alle estremità dei rami sono presenti dei medaglioni che accolgono miniature rinascimentali chiuse da cristalli di rocca, mentre sul retro sono eseguite figure in smalto traslucido. Intorno ai medaglioni si ammirano incastonati dei rametti di corallo rosso, che si vedono alternati anche ai rami di metallo lungo tutto il tronco. Sulla sommità dell’albero, infine, sono collocati un Cristo crocifisso e un pellicano che si becca il petto per sfamare i suoi piccoli, allegoria del sacrificio di Gesù che versò il proprio sangue per salvare l’umanità.
Viaggio tra i capolavori d’arte sacra delle chiese lucignanesi
Lucignano vanta un importante patrimonio religioso. La Collegiata di San Michele Arcangelo fu eretta a navata unica tra il 1594 e il 1616 su progetto di Orazio Porta e venne rimaneggiata nella seconda metà del Seicento. Sul luogo dell’edificio religioso in precedenza si trovavano i resti di una rocca di origine longobarda, a cui era stata addossata la scomparsa Chiesa di San Michele. La Collegiata è a croce latina e provvista di una cupola ottagonale. La scenografica scalinata dalla forma ellittica in travertino di accesso fu disegnata nel 1712 da Andrea Pozzo, autore anche del prezioso altare maggiore di inizio Settecento dedicato ai SS. Pietro e Paolo. Dall’interno della chiesa, che custodisce notevoli tele seicentesche di autori vari, si accede alla Cappella del Santissimo Sacramento, dove sono presenti il “Crocifisso miracoloso” ligneo del XIV attribuito al Maestro di Camaiore e le “Storie del Vecchio e del Nuovo Testamento” dipinte agli inizi del XIX secolo da Luigi Ademollo.
La Chiesa di San Francesco, con la sua caratteristica facciata con fasce orizzontali di arenaria e travertino alternate, fu costruita in stile gotico tra il 1248 e il 1289. Nonostante la perdita di importanti affreschi trecenteschi di autori vari e la lacunosità di altri, a causa dei rimaneggiamenti che tra la fine del Cinquecento e il secolo successivo addossarono alle pareti nuovi altari, l’edificio conserva ancora numerosi capolavori pittorici. I più noti sono l’affresco nella parete destra con il “Trionfo della morte” di fine Trecento attribuito alla cerchia di Bartolo di Fredi , la statua con la “Madonna di Crespignano” di Mariano di Agnolo Romanelli del 1380-90 e il polittico con la “Madonna con il Bambino e santi” di Luca di Tommè dietro all’altare maggiore, anche questo della seconda metà del XIV secolo.
A sinistra della chiesa si trova l’accesso all’affascinante chiostro del convento francescano,
mentre a destra è addossato l’Oratorio del Corpus Domini di fine Quattrocento, oggi Sala “Don Enrico Marini”, utilizzata per mostre e conferenze. A breve distanza sorge la Chiesa della Santissima Annunziata, fatta ristrutturare dall’omonima compagnia nel 1582. Oggi appartiene all’Arciconfraternita della Misericordia, che nella sacrestia ha allestito il Museo della Carità con arredi, indumenti e mezzi utilizzati in passato dalla società laicale. Completano il percorso dedicato alle chiese del centro storico la Chiesa del Crocifisso o di Santa Margherita con l’altare cinquecentesco, che custodiva in passato il “Crocifisso miracoloso” della Collegiata, e l’Oratorio di San Giuseppe di origine quattrocentesca.

La Fortezza incompiuta e le chiese incastonate nell’idilliaca campagna
I dintorni lucignanesi offrono al visitatore alcuni degli scorci più suggestivi della Val di
Chiana aretina. A nord ovest del centro storico si possono visitare i resti della Fortezza Medicea voluta nella seconda metà degli anni Cinquanta del XVI secolo dai fiorentini, solo parzialmente realizzata su progetto di Bernardo Puccini, e il vicino Santuario della Madonna delle Querce risalente alla seconda metà del XVI secolo, il cui progetto è assegnato a Giorgio Vasari. L’edificio sacro fu costruito nei pressi di una fonte “galattofora”, frequentata
per secoli dalle partorienti lucignanesi perché si credeva che le sue acque favorissero la lattazione. Lungo l’antica strada, che uscendo da Porta San Giovanni conduce a Foiano della Chiana, si trovano il Convento dei Cappuccini di fine Cinquecento e la Chiesa di San Biagio in località Pieve Vecchia, che in passato era la Pieve di San Felice in Sibano, edificio romanico rinnovato alla fine del Settecento, di cui resta la torre campanaria del XII secolo.
In località Calcione si ammirano infine il pittoresco lago derivato dalla diga sul torrente Foenna e l’imponente castello documentato dal X secolo e più volte rimaneggiato, appartenente ai nobili Pianetti Lotteringhi della Stufa.
Eventi e mostre di un borgo vivo tutto l’anno nel segno dell’arte, della cultura e del folklore
Accanto all’impegno costante per la valorizzazione della sua storia e dell’arte dal passato,
Lucignano è una realtà vivace grazie a eventi culturali, artistici, musicali e folkloristici di grande richiamo che scandiscono le stagioni. D’estate il centro storico si anima grazie a spettacoli e iniziative che coinvolgono tutte le fasce d’età. Mostre d’arte contemporanea
di maestri toscani dialogano periodicamente con le opere del Museo Civico, mentre nella Biblioteca Comunale vengono organizzate rassegne letterarie di qualità.
Gli scorci più belli del centro storico sono catturati ogni anno, a ottobre, da pittori che arrivano da tutta Italia per il concorso di pittura estemporanea organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il noto pittore di origine lucana Pasquale Di Fazio, che a Lucignano
ha il suo atelier. Il momento più atteso è però la “Maggiolata”, la festa della primavera per eccellenza dei lucignanesi e di tutta la Val di Chiana, che porta nel borgo un tripudio di colori, fiori ed emozioni.