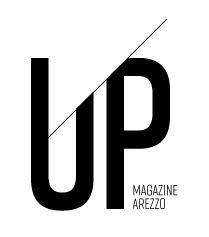Là dove nasce l’Arno, nel cuore delle Foreste Casentinesi, un territorio costellato di borghi silenziosi, possenti castelli e mistiche pievi romaniche

Geolocalizzazione
Natura, storia, arte e spiritualità connotano da sempre il territorio di Pratovecchio Stia, comune sparso che dal 2014 unisce gli antichi comuni di Pratovecchio e Stia, i primi bagnati dall’Arno. Il fiume sgorga infatti in terra stiana, sul Monte Falterona, e il Casentino è la sua prima conca, delimitata a est dall’Alpe della Serra e a ovest dal massiccio del Pratomagno. Ci troviamo nella parte più settentrionale della provincia di Arezzo, nel cuore magico del Parco Nazionale delle Fo- reste Casentinesi.
Stia, un’antica piazza mercantile piena di tesori
Stia, alla confluenza del torrente Staggia nell’Arno, nel Duecento era chiamata Palagio, in riferimento a un palazzo fortificato dei Conti Guidi documentato nel 1230, costruito a breve distanza di un importante crocevia, in cui si sviluppò nel medioevo un’area per il mercato. Quando nel 1402 entrò nell’orbita di Firenze, il luogo divenne Palagio Fiorentino e dopo il XVIII secolo assunse l’attuale denominazione. Oggi, per Palagio Fiorentino, si intende l’edificio fatto costruire in stile agli inizi del Novecento al posto di quello medievale rovinato nel corso del Quattrocento. L’elegante Piazza Tanucci, dalla tipica forma allungata e caratterizzata dai portici e da una fontana, è il cuore di Stia. Qui si trova la Pieve di Santa Maria Assunta, documentata dal 1017 e riedificata a metà del XII secolo. L’interno a tre navate conserva ancora lo stile romanico e capolavori che vanno dal XIII al XVIII secolo. Da visitare anche la Podesteria in Borgo Vecchio e vicolo dei Berignoli, in cui si possono vedere la Collezione Ornitologica “Carlo Beni”, e il Museo del Bosco e della Montagna.
Esterni al centro storico sono situati l’ex lanificio di inizio Ottocento, oggi Museo dell’Arte della Lana, e il settecentesco Oratorio della Madonna del Ponte, entrambi nei pressi del- la cascata dello Staggia. L’itinerario alla scoperta del territorio stiano ci porta a conoscere il quattrocentesco Santuario della Madonna delle Grazie, in località Santa Maria, costruito per ricordare un miracolo mariano. A Papiano, in direzione del passo della Calla, si trova la Chiesa di Santa Cristina che risale al XII secolo. A Porciano il Castello fu realizzato nell’XI secolo. Nel borgo sorto intorno al fortilizio si osserva anche la Chiesa di San Lorenzo di origine medievale. A Vallucciole la Chiesa dei SS. Primo e Feliciano ospita il sacrario delle vittime dell’agghiacciante eccidio nazista del 13 aprile 1944. Salendo sul Monte Falterona, infine, si raggiungono le sorgenti del principale fiume toscano, in località Capo d’Arno, e il Lago de- gli Idoli, dove nell’Ottocento fu scoperto un enorme deposito votivo etrusco.

Il Castello di Porciano, un luogo di dantesche memorie
A un chilometro e mezzo di distanza da Stia, su una collina a sinistra dell’Arno, il Castello di Porciano è uno dei simboli più noti del medioevo casentinese.
Il maniero è documentato agli inizi dell’XI secolo. In uno scritto del 1017 figura, infatti, come residenza del conte Guido di Teudegrimo, capostipite del ramo dei Conti Guidi di Porciano Modigliana, che da lì controllava la valle fino al territorio bibbienese e le strade verso il Mugello e la Romagna. Agli inizi del XIV secolo Dante Alighieri fu ospite del fortilizio durante il lungo esilio da Firenze. Secondo la tradizione, nel 1311 il poeta vi scrisse tre celebri lettere: “Al Principe e al Popolo d’Italia”, “Ai Fiorentini” e “A Enrico VII”.
L’ultimo esponente della casata, il conte Ludovico Guidi, nel 1442 rinunciò alla contea e si fece monaco. Il luogo passò così sotto il controllo diretto della Repubblica Fiorentina e cominciò il lento declino di Porciano. Nel 1799 i Conti Goretti de’ Flamini acquistarono il maniero, che in molte sue parti era ormai diroccato. Dagli anni Sessanta del secolo scorso partirono i lavori di recupero. Dopo gli ultimi interventi del 1975, il castello tornò a vivere e nel 1978 fu inaugurato al suo interno 19 un composito museo, oggi inserito nella rete dell’Ecomuseo del Casentino. L’elemento più evidente è la possente Torre dotata di merlatura alla guelfa, che con i sui 35 metri è la più alta del Casentino.
Pratovecchio, un borgo ricco di capolavori… e portici
Il nucleo più antico di Pratovecchio nacque nel XII secolo, quando i Conti Guidi fondarono un borgo fortificato lungo le sponde dell’Arno. L’antica area del castello corrisponde all’odierna Piazza Landino, che assieme alla vicina Piazza Paolo Uccello mostra i porticati tipici di tutto il paese.
Sulla prima piazza citata gravitano gli edifici pratovecchini principali, a partire dalla Propositura del Ss. Nome di Gesù, costruita tra il 1592 e il 1661, che custodisce capolavori dal XIII al XVII secolo, come la stupenda “Madonna in trono con il Bambino” di fine Duecento attribuita al Maestro di Varlungo. Al XII secolo risale il Monastero di San Giovanni Evangelista, mentre cinquecentesco è il Monastero di Santa Maria della Neve. Sempre in Piazza Landino si trova Palazzo Vigiani, sede del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. A breve distanza dalla piazza sono collocati la Podesteria quattrocentesca e il Teatro degli Antei, sorto nel 1719 per volere dell’omonima accademia. Nei dintorni di Pratovecchio, oltre la sponda sinistra dell’Arno, si può visitare la Badia di Poppiena risalente all’XI secolo, con la sua Chiesa di Santa Maria. A seguire, lungo la via per Camaldoli, si incontrano Ama con la Chiesa di San Biagio dell’XI secolo, Lonnano con la Chiesa dei SS. Vito e Modesto del XII secolo e Valiana con la Chiesa di San Romolo del XII secolo, le tre tappe principali di un percorso tra fede e natura che regala suggestioni uniche. Oltre la sponda destra dell’Arno si trova invece Romena, con il celebre Castello dei Conti Guidi. Alle pendici del colle fortificato
20 sorge la Pieve di San Pietro, capolavoro architettonico dell’XI secolo. A metà strada tra
l’edificio religioso e la roccaforte si vede infine la Fonte Branda, che rimanda a Mastro Adamo da Brescia, personaggio inserito da Dante Alighieri nel XXX canto dell’Inferno, che nel 1281 pagò con la vita l’aver falsato i fiorini della Repubblica Fiorentina.
Il Castello di Romena, un simbolo dei Conti Guidi in Casentino
Per chi vuole vivere la magia del medioevo, il Castello di Romena è un luogo perfetto. Nel 1008 la località e il suo fortilizio erano sotto il controllo dei Marchesi di Spoleto. Nel corso dell’XI secolo la proprietà passò ai Conti Alberti. La contessa Ermellina, a cavallo tra XI e XII secolo, portò il maniero in dote nel suo matrimonio con il conte Guido IV. Da allora Romena divenne uno dei simboli del dominio casentinese dei Conti Guidi, che potenziarono il fortilizio a più riprese e dal 1213, con Aghinolfo, inaugurarono il ramo di Romena. Il XIII secolo è un periodo di grande sviluppo del borgo fortificato, con il rialzamento della Torre del Mastio e della Torre della Postierla, la costruzione del Palazzo Comitale e della Torre delle Prigioni, il rialzamento della cinta interna del Cassero e la realizzazione di una terza cerchia con undici torri perimetrali e quattro porte di accesso, di cui rimangono ben conservate Porta Bacia e Porta Gioiosa. All’inizio del XIV secolo anche questo castello
ospitò Dante Alighieri, esiliato da Firenze. Tra il 1357 e il 1359 i Conti Guidi cedettero in accomandigia i diritti del luogo alla Repubblica Fiorentina. Persa la sua importanza militare, dal Cinquecento il maniero andò incontro a un progressivo degrado. Tra il 1768 e il 1786 i Conti Goretti de’ Flamini acquistarono i ruderi e alcuni edifici nelle immediate pertinenze dell’ex roccaforte. Grazie al conte Ottaviano, nella prima metà del secolo scorso iniziò il lungo recupero. Dalla sua apertura al pubblico del 2007, il Castello di Romena musealizzato è ogni anno uno dei luoghi più visitati dell’intero Casentino.
Mistero e spiritualità nelle antiche pietre della Pieve di Romena
La Pieve di San Pietro a Romena, alle pendici del colle dominato dal castello dei Conti Guidi, è a pieno titolo il capolavoro assoluto del romanico in Casentino. L’edificio, dichiarato monumento nazionale, fu costruito nel 1152 dal pievano Alberico. Come recita l’abaco del primo capitello di sinistra, la pieve fu realizzata in tempo di carestia da maestranze locali e lombarde con influssi d’oltralpe.
Toponimo di origine etrusca, Romena probabilmente ospitava già un tempio che fu frequentato anche in epoca romana. Sull’edificio pagano in seguito ne sorse uno cristiano. Scendendo nel sottochiesa, si possono ammirare le tracce di una chiesa altomedievale triabsidata realizzata tra l’VIII e il IX secolo. Sopra i resti di questa struttura Alberico fece edificare la chiesa battesimale a tre navate e sette campate, di cui ne sopravvivono solo cinque a causa di una frana del 1678, che portò in dote una nuova facciata in pietre conce e un edificio più piccolo. Il terremoto nel 1729 fece nuovi danni, come il crollo parziale della torre campanaria. Per fortuna rimase intatta l’abside, con due ordini di arcate sovrapposte e un tripudio di colonnette, monofore, bifore e trifore.
All’interno la pietra austera e la luce che filtra in modo parziale immergono il visitatore in una dimensione mistica straordinaria, nella quale sacro e profano si intrecciano senza soluzione di continuità. Ogni capitello che sormonta le possenti colonne cilindriche è un piccolo universo scolpito di figure umane, animali reali e mitologici, citazioni bibliche, motivi vegetali e altri simboli. Oggi la pieve ospita la Fraternità di Romena, una comunità fondata nel 1991 da don Luigi Verdi, adatta a chiunque, laico o religioso, abbia la voglia di tornare in contatto con se stesso, gli altri e la natura